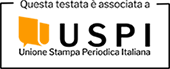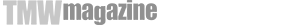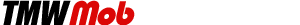TUTTO mercato WEB
TUTTO mercato WEBUna Juventus in transizione, perde con onore punita dalla V. AR.
Esistono momenti in cui il calcio smette di essere un gioco e diventa una ferita aperta nella nostra percezione del Giusto. La decisione arbitrale (in campo e al monitor) di ieri sera di espellere Kalulu e lasciare la Juventus in dieci non è stata un semplice "errore umano", ma una rottura del patto fiduciario tra lo sport e chi lo osserva. Qui non parliamo di dubbi, ma di quella vergogna che, come suggerisce la sua definizione più profonda, non nasce da una colpa propria, ma dal turbamento mortificante davanti all'indecenza altrui. Forse finalmente abbiamo decriptato l’acronimo V.AR.: vergogna arbitrale.
La vergogna che abbiamo provato è un sentimento aristotelico: è lo sconcerto di fronte a un atto che nega l'evidenza del mondo sensibile. Quando la tecnologia e l'occhio umano si fondono per produrre un'ingiustizia palese, non viene solo danneggiata una squadra — in questo caso la Juventus nel suo faticoso cammino di transizione — ma viene umiliata la verità. In filosofia, il "simulacro" è una immagine, copia, rappresentazione che ha perso il suo legame con la realtà originale, diventando una forma autonoma che simula la realtà stessa. La decisione del signor La Penna e delle sue pedine variste è stata esattamente una parvenza di applicazione del regolamento che, nella sostanza, ne ha tradito l'anima. Vedere l'arbitro sordo al richiamo della realtà trasforma il campo di San Siro in un teatro dell'assurdo di Ionesco, dove le parole e i fischietti perdono il loro significato condiviso. La rabbia bianconera non è solo per un punto perso o per una classifica alta ma complicata, ma per la sensazione di aver assistito a un sacrilegio laico. In un anno in cui la Juventus accetta con umiltà i propri limiti e le proprie macerie, subire un'ingiustizia così netta è come ricevere uno schiaffo mentre si sta cercando di rialzarsi da terra con dignità. Se il male, come scriveva Hannah Arendt, può essere banale, l'ingiustizia arbitrale è spesso burocratica. Si nasconde dietro protocolli oscuri e interpretazioni bizantine per coprire un vuoto di coraggio. Questa "vergogna" non appartiene a chi la subisce, ma macchia indelebilmente chi l'ha commessa e chi, col silenzio, l’avalla. La Juventus di quest'anno non ha bisogno di alibi, ma ha il diritto sacrosanto alla linearità del destino. Se deve cadere, che cada per i suoi errori, non per un decreto iniquo emesso in mondovisione. Ora si parlerà di episodi, di moviole e di centimetri, ma il residuo morale di questa notte rimarrà: la sensazione che il calcio, a volte, preferisca la propria narrazione alla propria verità. La Juventus torna a casa con la consapevolezza che la sua transizione (che a me sta apparendo positiva) sarà ancora più dura del previsto, perché oltre ai propri fantasmi dovrà combattere anche contro quelli che portano il fischietto al collo e che inventano regolamenti antisportivi.
Per la Juventus questo è un altro anno cruciale di passaggio. Esiste una crudeltà sottile nel concetto di "anno di transizione". Per la Vecchia Signora, storicamente abituata a coniugare il verbo vincere al presente indicativo, questo limbo cronico si sta trasformando in una sorta di esilio spirituale. Non è solo assenza di trofei; è una sospensione dell'essere. Se per decenni il motto bianconero è stato un imperativo categorico di stampo kantiano, un dovere che non ammetteva repliche, oggi quel "Fino alla fine" somiglia pericolosamente all'attesa dei personaggi di Samuel Beckett. Siamo in una versione calcistica di Aspettando Godot, dove il vincere (trofei) è quel protagonista che tutti citano, che tutti attendono sul ciglio della strada, ma che non si presenta mai all'appuntamento. La filosofia juventina si è sempre fondata sulla solidità del risultato, inteso come unica prova ontologica dell'esistenza del club. "Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta" non era solo uno slogan, ma l'architrave di una cattedrale. Senza quella pietra angolare, la cattedrale resta in piedi, certo, ma diventa un museo: bello da visitare, pieno di ricordi, ma privo di una funzione vitale nel presente. Ci troviamo di fronte al paradosso della Nave di Teseo citato da Plutarco: se cambiamo l'allenatore, i dirigenti, i calciatori e persino la filosofia di gioco, quella che scende in campo oggi è ancora la Juventus, quella cinica, implacabile, basata in passato sull’estetica del potere? Eppure dopo la partita di ieri sera dobbiamo immaginare lo juventino felice, perché - come direbbe Albert Camus - la squadra è riuscita a trovare dignità nella fatica di ricostruire ogni volta la base della montagna.
Esistono sconfitte che, paradossalmente, pesano più di una vittoria ottenuta per inerzia. La notte di San Siro, per questa Juventus in perenne bilico tra ciò che era e ciò che sarà, si è trasformata in un’epopea della "minoranza". Perdere in dieci uomini, combattendo contro il destino e contro l'asimmetria numerica, non è un semplice dato statistico: è un atto di resistenza estetica. Quando il rosso ha squarciato il verde del prato, la Juventus non ha perso solo un giocatore; ha perso l'equilibrio dell’architettura spallettiana. Eppure, in quel vuoto è emersa la ritrovata forza dell’anima bianconera. Giocare in dieci ha trasformato la partita in una prova di stoicismo puro. Se l'undici rappresenta la completezza e l'ordine, il dieci è il numero della lotta contro il caos. La squadra non ha più giocato per il risultato, ma per la propria dignità, cercando di colmare con il cuore i metri che la logica tattica dichiarava perduti. In questo anno ancora di transizione, in questo tempo sospeso, la Juventus ha scoperto dopo la battaglia di San Siro che si può essere aristocratici anche nel fango, mantenendo un portamento che il tabellino non può scalfire. La vergogna della decisione arbitrale di cui parlavamo prima viene qui lavata dall'onore della prestazione. La lotta verso la cima basta a riempire il cuore di un uomo e da ieri sera abbiamo il dovere di immaginare una Juventus felice nel suo sforzo sovrumano. Non c'è stata la sottomissione del debole, ma la fierezza del caduto.
Non è nel vincere senza ostacoli che si misura la grandezza, ma nel rendere difficile la vittoria del nemico quando tutto intorno a te sembra crollare. Mentre i rivali festeggiano i tre punti, la Juventus si porta a casa qualcosa di più sottile e duraturo: la consapevolezza che le sue fondamenta — quelle che stiamo cercando di riparare da mesi — sono fatte di una pietra che non si sgretola sotto la pressione. È la nobiltà della sconfitta onorevole, un concetto che nella letteratura cavalleresca vale più di un regno conquistato con l'inganno. Usciamo da San Siro senza punti, ma con una bussola. In un anno di passaggio, capire chi è disposto a correre il doppio per coprire il vuoto del compagno è la scoperta più preziosa. La transizione bianconera continua, ma da ieri la Juventus ha smesso di essere un'idea astratta per diventare un corpo d’acciaio unito, vivo e fiero.
Roberto De Frede
 potenzaPotenza-Team Altamura, ecco quanti biglietti sono stati venduti nel settore ospiti
potenzaPotenza-Team Altamura, ecco quanti biglietti sono stati venduti nel settore ospiti
 juventusJuventus: obiettivo Marcos Senesi a parametro zero
juventusJuventus: obiettivo Marcos Senesi a parametro zero
 perugiaLe date e gli orari di tutte le gare del Perugia rimaste nel campionato di C: oggi alle 17.30 la partita al Curi contro il Carpi
perugiaLe date e gli orari di tutte le gare del Perugia rimaste nel campionato di C: oggi alle 17.30 la partita al Curi contro il Carpi
 juventusJuventus, sondaggio per Bernardo Silva
juventusJuventus, sondaggio per Bernardo Silva
 interL'Inter sfata il tabù dei big match. Chivu non scagiona Kalulu: le top news del 14 febbraio
interL'Inter sfata il tabù dei big match. Chivu non scagiona Kalulu: le top news del 14 febbraio
 interChivu non ha dubbi: "Kalulu non avrebbe dovuto mettere le mani addosso a Bastoni"
interChivu non ha dubbi: "Kalulu non avrebbe dovuto mettere le mani addosso a Bastoni"
 juventusUna Juventus in transizione, perde con onore punita dalla V. AR.
juventusUna Juventus in transizione, perde con onore punita dalla V. AR.
 serie cIl fatto della settimana - L'affaire Mandorlini e il lampo Cangelosi: quattro esoneri più una dimissione in sette giorni di follia pura
serie cIl fatto della settimana - L'affaire Mandorlini e il lampo Cangelosi: quattro esoneri più una dimissione in sette giorni di follia pura