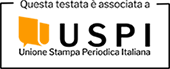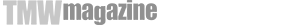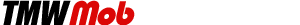ESCLUSIVA TA - Facchetti Jr: "Cresciuto nel vivaio della Dea, ma il cuore è interista. L'Atalanta deve superare il post-Gasperini. Su Carnesecchi..."
Figlio di una delle bandiere più luminose della storia dell’Inter e della nostra Nazionale, ma anche ex ragazzo del vivaio dell’Atalanta, Gianfelice Facchetti è una voce capace di attraversare il calcio da angolazioni diverse: il campo, la memoria, il racconto. Attore e scrittore, ha trasformato il pallone in materia narrativa, indagandone il valore culturale e umano oltre il risultato. Nei suoi lavori, tra cui lo spettacolo «Il Grande Torino. Una cartolina da un Paese diverso», in cui racconta in chiave teatrale la storia e le emozioni legate alla leggendaria squadra del Grande Torino e andato in scena in varie città italiane, anche recentemente, il calcio diventa racconto collettivo, memoria condivisa e chiave per leggere il presente. In questa intervista esclusiva a TuttoAtalanta.com, Gianfelice ripercorre il suo legame personale con Bergamo, gli anni nel settore giovanile nerazzurro, l’eredità di papà Giacinto e la convinzione che, anche dentro un calcio profondamente cambiato, esista ancora spazio per custodirne e rinnovarne il senso più vero e condiviso.
Gianfelice, pochi lo sanno, ma tu sei cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta. Ci racconti come eri arrivato nel vivaio ?
«Giocavo nella squadra del mio paese, a Cassano d’Adda, e mi aveva notato l’Atalanta. Avevo 12 anni e sono rimasto per quattro stagioni: due nei Giovanissimi e due negli Allievi. L’ultimo anno lo feci con Cesare Prandelli, che allora era alla sua prima esperienza da allenatore nel settore giovanile dell’Atalanta. Io facevo il portiere e ho avuto la fortuna di avere come primo preparatore il grandissimo Pierluigi Pizzaballa. Poi nel tempo ne ho avuto altri come Roberto Corti e Nello Malizia».
Che ricordi hai di quegli anni?
«Anni belli, in cui sono cresciuto - confida, in esclusiva a TuttoAtalanta.com -. Il gioco del pallone vissuto così ti avvicina al mondo dei sogni o quantomeno ti fa capire se quella può essere davvero la tua strada. Il mio non è stato un percorso lineare. Chiusa la parentesi degli Allievi, ho gironzolato un po’. Ho giocato alla Trevigliese, nel Leffe di Bortolo Mutti, in C1. Giocavo nella Berretti ed ero aggregato come portiere alla prima squadra».
Quando hai deciso di smettere?
«Tre anni dopo Leffe, a 21 anni. Ho fatto un paio si stagioni in Eccellenza e poi un anno di Interregionale ad Albino. Ho capito che la cosa non stava decollando come speravo. L’entusiasmo si era un po’ raffreddato e ho deciso di dedicarmi ad altro».
Hai deciso di restare nel mondo del calcio, ma in un modo diverso: raccontandone il senso più profondo
«Il mondo del calcio è stato la vita della mia famiglia, dentro e fuori dal campo. Le storie che giravano attorno al calcio erano storie familiari. Oggi, ad esempio, porto in giro uno spettacolo dedicato al Grande Torino, di cui mio padre mi aveva sempre parlato con grande affetto. Per la sua generazione quella squadra era vissuta come mitologica, ma lo stesso vale per tante altre realtà e figure. Quando ho iniziato a scrivere e a fare spettacoli sono andato spesso ad attingere volentieri dentro quel mondo, proprio perché erano storie familiari e perché ho sempre pensato che le storie di sport abbiano la stessa dignità di qualsiasi altra vicenda. Dipende da quello che ti danno la possibilità di raccontare. Si può parlare in profondità anche parlando di un atleta o di una disciplina sportiva».
Nei tuoi lavori, e in particolare nello spettacolo «La tribù del calcio», il pallone ruota attorno all’idea del calcio come rito collettivo. Secondo te oggi è ancora così? E c’è ancora spazio per quel «tifoso normale» di cui parli?
«Nel cuore della gente questo desiderio esiste ancora: c’è la speranza che quel modo di vivere il calcio, che lo ha reso lo sport più popolare in Italia, possa in qualche modo resistere. In realtà questa percezione si è un po’ intiepidita. Oggi c’è molta distanza tra i campioni e i tifosi. Una volta si mescolavano più facilmente alla gente e questo creava vicinanza, complicità, una sorta di sinergia naturale. Oggi, invece, gli stadi rischiano di diventare sempre più luoghi di consumo. I Club non puntano a tifosi fidelizzati o abbonati, ma su spettatori che vivono l’evento solo come un’esperienza: vengono, vivono la giornata e tutto ciò che ruota attorno allo spettacolo sportivo e la volta dopo ne arrivano altri. È un modello che privilegia l’esperienza momentanea più che il legame che dura nel tempo».
A tuo papà sarebbe piaciuto questo calcio "globale", tra Supercoppe in Arabia e gare in Australia?
«Mio padre ha attraversato tante stagioni del calcio. È cresciuto durante la guerra e ha iniziato a giocare nel periodo del boom economico, quando il pallone cominciava già a essere legato alla ricchezza e alla fortuna. Anche allora, rispetto alle generazioni precedenti, qualcuno diceva che c’erano troppi soldi. Poi è rimasto dentro al calcio come dirigente e presidente, proprio negli anni in cui arrivavano i diritti televisivi e la torta si faceva sempre più grande. Non si è mai scandalizzato di quei cambiamenti che nascono da una richiesta, perché esiste un mercato. Non è necessariamente tutto negativo. La vera sfida è riuscire, nella modernità, a mantenere il senso profondo e l’autenticità di uno sport. Non perdere le cose belle che hanno reso il calcio qualcosa di tutti. Se si va a giocare una finale o un trofeo in un Paese lontano, che apparentemente non c’entra con la nostra storia, va bene, purché non si faccia solo per soldi. Portiamoci anche la cultura del pallone, quella che ha reso il calcio italiano ciò che è stato. Che sia un’opportunità fino in fondo: non solo economica, ma anche culturale. Un’occasione di scambio, di conoscenza reciproca tra mondi che spesso si osservano, ma non dialogano davvero».
Tuo papà lasciò la Trevigliese per andare all’Inter. È vero che non gli sarebbe dispiaciuto andare anche all’Atalanta?
«Mio padre fece praticamente in contemporanea il provino con Atalanta, Milan e Inter. Il Milan non si fece vivo a stretto giro, mentre si fecero subito avanti Inter e Atalanta. Il prete dell’oratorio, che era tifoso atalantino, cercò d’indirizzarlo verso Bergamo. Mio nonno, invece, era interista e in qualche modo prese in mano la regia del trasferimento, mandandolo a Milano. Però mio padre ha sempre avuto una simpatia per l’Atalanta, che poi si concretizzò anche in un breve passaggio in società negli anni di Bortolotti».
Raccontaci di più del legame di papà con l’Atalanta
«Negli anni di Cesare Bortolotti mio padre è stato vicepresidente dell’Atalanta per una stagione, la 1980-81, quando la squadra era in Serie B. Bortolotti veniva spesso a San Siro a vedere l’Inter e c’era un rapporto molto stretto, fatto di stima e di amicizia vera. Anche Ivan Ruggeri è stato uno dei suoi amici più cari. Insieme hanno condiviso tanti momenti. Aveva un legame forte anche con la famiglia Radici».
Quindi il legame con Bergamo non era solo calcistico
«Mio padre era bergamasco, veniva da Treviglio e il legame con Bergamo era profondo. Aveva aperto un’agenzia di assicurazioni sia a Milano che a Bergamo ed era innamorato di alcuni luoghi della città: Città Alta, il Sentierone, il Balzer. Negli ultimi anni, quando poteva, tornava spesso. Persino il suo parrucchiere era sotto i portici del Sentierone. Aveva queste due anime: quella milanese, legata all’Inter, e quella bergamasca, molto radicata. Il suo luogo delle vacanze per eccellenza era stato prima il Monte Poieto e poi Selvino».
A voi figli ha lasciato qualcosa dell’Atalanta?
«Ovvio che il tifo vero, quello profondo, sia rimasto l’Inter, perché era la squadra della vita di mio padre ed è quello che ho respirato crescendo, ma l’Atalanta mi è sempre stata simpatica. Da ragazzo, quando giocavo nel settore giovanile, ho visto tantissime
partite. Papà non voleva che andassi in Curva a San Siro perché ero troppo piccolo. Allora andavo di nascosto allo stadio con i miei compagni. Dicevo che andavo a studiare o che uscivo, non specificavo dove. Quindi, per un periodo, più Atalanta che Inter. Ho seguito tutta la cavalcata della Coppa delle Coppe nell’anno della semifinale con il Malines. Ho visto tutte le partite di campionato a Bergamo e andavo anche in trasferta con il papà di un mio compagno. Erano gli anni di Garlini, che giocava in maniera splendida. Una simpatia che non se n’è mai andata».
Tuo papà è stato capitano dell’Inter in un'epoca in cui la parola bandiera aveva un peso. Secondo te oggi esistono ancora bandiere come lui?
«È più complicato, ma non credo, come spesso si dice, che oggi i giocatori siano mercenari. È un mondo che vive di cambiamenti continui. Lo scenario di famiglie storiche alla proprietà di Club a Milano e Bergamo oggi sembra irripetibile. In mezzo a tanti cambiamenti di proprietà e dirigenza è più difficile che i giocatori riescano a restare nel tempo. Se però guardo, per esempio, all'Inter, negli ultimi anni ci sono stati giocatori che si sono legati alla maglia e al Club, vedi capitan Lautaro Martinez o Nicolò Barella. Forse dopo tanti cambiamenti arriva un momento di assestamento in cui si capisce che certi fenomeni, come quelli del tutti in Cina, si traducono in bolle di sapone che durano solo un paio d'anni. Io ho la sensazione che forse qualche passettino indietro qualcuno stia tentando di farlo».
Secondo te mister Chivu incarna i valori della famiglia Facchetti: vincere, ma con stile e rispetto?
«A me è sempre piaciuto, anche quando allenava nel settore giovanile, dove aveva meno visibilità. È entrato in punta di piedi nel mondo Inter e si sta facendo apprezzare. Con il lavoro ha portato buoni risultati perché è riuscito a rivitalizzare un gruppo che doveva ricominciare con nuove motivazioni dopo la fine di un ciclo. Non sono mai facili le fasi di passaggio in un gruppo in cui qualcuno è a fine corsa e altri devono subentrare. Lui ha lavorato con quello che gli è stato messo a disposizione senza grande clamore. In un mondo di urlatori, di gente che fa sceneggiate a bordo campo con arbitri o dirigenti avversari, a me lo stile di Chivu piace molto e mi ci riconosco».
Dell’Atalanta invece cosa ne pensi?
«L’Atalanta sta affrontando un passaggio molto delicato. In campo scendevano i giocatori, ma negli ultimi anni, volenti o nolenti, era diventata il riflesso di Gasperini sia per i risultati che per ciò che lui ha rappresentato: un’identità fortissima, un’idea di calcio, un ciclo irripetibile culminato con l’impresa dell’Europa League. Quando una figura così centrale e così vincente si sposta, diventa inevitabilmente anche ingombrante nel momento della successione. Non è facile capire come ripartire, né scegliere la strada giusta. Il passaggio con Juric non ha sortito gli effetti sperati. Palladino mi sembra una figura moderata, che forse può portare un approccio diverso. L’Atalanta può ritrovare la propria dimensione naturale: una squadra stabilmente di alta classifica, senza l’urgenza ossessiva di dover per forza replicare subito quei picchi straordinari. I giocatori ci sono, la proprietà è solida e competente e sa lavorare. Serve solo metabolizzare il cambiamento. A volte questi passaggi vengono facilitati dai risultati, che però non sempre rispondono alla logica del campo. A volte c’è un pizzico di buona sorte che t’incoraggia e ti spinge in avanti, altre volte i tempi si allungano perché bastano tre risultati negativi per entrare in un circolo vizioso difficile da rompere, anche perché in questo momento la competitività in serie A è alta, anche se nessuno corre».
Visto che è stato uno dei grandi temi dell’estate: Lookman avrebbe fatto comodo all’Inter?
«Penso proprio di sì. Lookman è un ottimo giocatore, ma la sua mancata acquisizione ha permesso all’Inter di scoprire altre soluzioni offensive. Ha preso Bonny e ha valorizzato giocatori che magari non avrebbero avuto così tanto spazio se fosse arrivato un titolare fisso come Lookman, vedi Pio Esposito. Ci sarebbe stato meno avvicendamento. Alla fine, per come sono andate le cose, va bene così».
Da ex portiere a portiere: Carnesecchi è da Nazionale?
«Assolutamente sì. In questo momento credo sia il portiere italiano più forte in Serie A. Ci sono Donnarumma e Vicario, ma Carnesecchi può tranquillamente essere titolare in Nazionale».
Alla luce della classifica, Atalanta-Inter è ancora un big match?
«Sì, resta un big match. Sono comunque due squadre con rose di livello alto. E poi c’è un dato interessante: l’Atalanta, pur nelle difficoltà in campionato, ha avuto fin qui un cammino quasi perfetto in Champions League. Ha trovato in Europa quei risultati che non sempre è riuscita a trovare in Serie A. A volte giocare allo stesso modo su due fronti non è semplice, non sempre ci si riesce, ma il confronto tra le due squadre nerazzurre resta una partita di vertice, anche se l’Atalanta in questo momento è più indietro in campionato. Io ricordo ancora la partita a Bergamo dello scorso anno e la coreografia con ago e filo, l’idea di “cucire” il Tricolore perché in quel momento della stagione sembrava davvero una sfida decisiva per il titolo italiano».
Che partita ti aspetti?
«Non una gara giocata d’impeto. In Europa c’è una predisposizione delle squadre a giocare di più, a scoprirsi, a correre rischi. In campionato invece prevale la prudenza, con l’obiettivo del risultato. Non mi aspetto quindi un’Atalanta all’arrembaggio a tutti i costi, ma una squadra che vuole dare continuità e migliorare una striscia di risultati positivi per non interrompere il ciclo che ha appena inaugurato».
E l’Inter?
«Ha appena riconquistato il primo posto, con margini minimi: un punto sul Milan, due sul Napoli. Il gruppo di testa è molto corto. L’obiettivo sarà restare in vetta, con prudenza e attenzione».
Vedi l’Inter come favorita per lo Scudetto?
«In estate non la consideravo come favorita assoluta perché c’erano molte incognite. Oggi, dopo queste prima fase di campionato dove la testa della classifica è cambiata spesso e nessuno è scappato via davvero, credo che l’Inter possa giocarsela, anche sa vedo più avanti il Napoli perché ha una rosa molto strutturata e profonda e ha investito tanto sul mercato. Il Milan, non giocando le Coppe europee, ha il vantaggio di potersi concentrare su una partita a settimana e questo incide. L’Inter, però, mi sembra un gruppo che ha voglia di riprendersi quel qualcosa che l’anno scorso ha lasciato per strada. Sta ritrovando entusiasmo e questo può diventare un ingrediente decisivo».
Tra ricordi, stadi vissuti senza barriere e una concezione del calcio come patrimonio condiviso, il racconto di Gianfelice Facchetti restituisce uno sguardo concreto, ma mai nostalgico. La modernità non viene rifiutata, ma interrogata: può convivere con l’autenticità, con lo stile, con il rispetto che hanno reso il calcio qualcosa di più di un semplice spettacolo? Nel filo che unisce Inter e Atalanta, Milano e Bergamo, passato e presente, resta una certezza: finché il pallone saprà raccontare storie, creare appartenenza e parlare alle persone, il rito collettivo non sarà mai davvero finito.
© Riproduzione Riservata

 juventusZidane nuovo ct della Francia: impatto decisivo sul mercato e sulle strategie dei calciatori francesi
juventusZidane nuovo ct della Francia: impatto decisivo sul mercato e sulle strategie dei calciatori francesi
 atalantaESCLUSIVA TA - Facchetti Jr: "Cresciuto nel vivaio della Dea, ma il cuore è interista. L'Atalanta deve superare il post-Gasperini. Su Carnesecchi..."
atalantaESCLUSIVA TA - Facchetti Jr: "Cresciuto nel vivaio della Dea, ma il cuore è interista. L'Atalanta deve superare il post-Gasperini. Su Carnesecchi..."
 juventusMilan, colpo a sorpresa, si punta su un ex obiettivo Juve
juventusMilan, colpo a sorpresa, si punta su un ex obiettivo Juve
 juventusBoom, svelati i cinque nomi!
juventusBoom, svelati i cinque nomi!
 juventusEcco il prezzo di Raspadori
juventusEcco il prezzo di Raspadori
 atalantaAtalanta-Inter, le probabili formazioni
atalantaAtalanta-Inter, le probabili formazioni
 juventusRoma, pericolo Zirkzee
juventusRoma, pericolo Zirkzee
 fiorentinaParma-Fiorentina, le probabili formazioni: Viti in pole per sostituire Ranieri, confermato Parisi
fiorentinaParma-Fiorentina, le probabili formazioni: Viti in pole per sostituire Ranieri, confermato Parisi