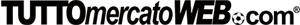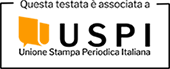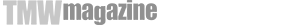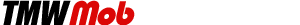TUTTO mercato WEB
TUTTO mercato WEBJuve è crisi? Magari…!
Ecco mal digerita la prima amichevole estiva, dopo il grande boom economico del campionato del mondo americano. Quando si vince una amichevole estiva, si esalta il trionfatore oltremodo e in maniera infruttifera. Quando si perde, idem al contrario. E quando si pareggia… mah! È bastata la Reggiana con un 2 a 2 a mettere in “crisi” la Juventus, come molti hanno sentenziato? Magari… e vediamo perché.
Le parole fanno anche paura. Anche? Sì, anche, cioè unitamente al mistero che recano in sé: continuamente e proprio quando sembra che siano chiare e ben collocate nell’uso che i parlanti ne fanno. Alcune di esse fanno più paura di quanto possiamo immaginare, specie se scelte con leggerezza e, in particolare, con riferimento alla vita economica di un paese o perché no, di una società sportiva o di un suo momento particolare; provocano, sulle prime, un effetto risonanza e, nel tempo, un effetto anestetico. Tutti finiscono coll’adottarle liberamente e in modo pervasivo, senza tuttavia conoscerne il vero significato. In verità, il termine “significato” è inadeguato; è opportuno parlare di “senso”, cioè del valore che una parola assume in un determinato contesto e in relazione con altre parole.
Se consultiamo i dizionari, a proposito del lemma “crisi”, troviamo una comune definizione: “improvviso passaggio dalla prosperità alla depressione”. Le sfere semantiche prevalenti, in realtà, sono due, quella economica e quella medico-sociale. Perché si dice “crisi” con tanta enfasi e, talora, non senza superficialità, come se si trattasse di un espediente linguistico universale? Sappiamo, per consuetudine, che una crisi si caratterizza per il calo di qualcosa di positivo e l’eccesso di qualcosa di negativo, soprattutto in economia. La più nota tra le crisi della storia, la crisi per antonomasia, è senza dubbio quella del 1929, anno in cui crollò Wall Street. Da quella grande crisi, infatti, si giunse a una recessione che durò non meno di un decennio. L’immagine mentale che dobbiamo cominciare a costruire per comprendere appieno senso e significato di “crisi” è quella del passaggio di stato, del brusco mutamento, dell’alterazione imprevista di alcune condizioni.
Da un punto di vista filologico e semantico, non si fa fatica a sconfessare i media. Pertanto, molto di frequente, i significati originari vengono abbandonati a vantaggio di acquisizioni ‘relazionali’. Il lettore che non ha dimestichezza con greco, latino e radici indoeuropee, tuttavia, sarà sorpreso nello scoprire che kρίσις (krìsis), derivando da kρίνω (krìno), come ci fa notare il linguista e grecista francese Pierre Chantraine, in origine, non aveva affatto il significato che oggi siamo soliti attribuire a essa. Il verbo greco κρίνειν (krìnein), pur non escludendo il significato di vagliare, aveva principalmente quello di separare, in virtù della propria radice, ed era connesso con la trebbiatura. In pratica, indicava l’attività di separare la granella del frumento dalla paglia e dalla pula; poi, per traslazione, il lemma è passato nell’atto dello scegliere. La crisi, dunque, contiene in sé una scelta fatta dopo una separazione, un taglio. Non è escluso, infatti, che l’accezione negativa sia stata dedotta proprio dalla necessità di separare qualcosa da qualcos’altro, tagliare, per l’appunto, ed essere costretti a una rinuncia, o meglio invogliati ad una scelta.
Si certo, sperando che la Vecchia Signora – in crisi nel senso or ora espresso - non faccia scelte sbagliate, buttando via il grano e tenendosi ben stretti paglia e pula.
Roberto De Frede
 juventusVlahovic futuro da definire
juventusVlahovic futuro da definire
 fiorentinaFlavio Cobolli sponsorizza Kean per la Roma: "Mi piacerebbe molto"
fiorentinaFlavio Cobolli sponsorizza Kean per la Roma: "Mi piacerebbe molto"
 atalantaESCLUSIVA TA - Il "Modello Zingonia" studiato all'Università, Capuzzi: «Un sistema unico, il vivaio della Dea vale il 46% delle plusvalenze: ecco perché vince»
atalantaESCLUSIVA TA - Il "Modello Zingonia" studiato all'Università, Capuzzi: «Un sistema unico, il vivaio della Dea vale il 46% delle plusvalenze: ecco perché vince»
 atalantaPalladino in conferenza: "Li ho studiati a Londra, ma in campo servono i fatti. Classifica? Non la guardo, conta solo vincere"
atalantaPalladino in conferenza: "Li ho studiati a Londra, ma in campo servono i fatti. Classifica? Non la guardo, conta solo vincere"
 atalantaDe Ketelaere in conferenza: "Chelsea? L'occasione per entrare tra le grandi. Io leader? Ora sento la responsabilità"
atalantaDe Ketelaere in conferenza: "Chelsea? L'occasione per entrare tra le grandi. Io leader? Ora sento la responsabilità"
 torinoCairo: “Baroni è confermato, non è questo il tema. Mercato di gennaio? Pensiamo a tutto”
torinoCairo: “Baroni è confermato, non è questo il tema. Mercato di gennaio? Pensiamo a tutto”
 milanClonate Pulisic! Il Milan non molla niente! Rabiot straripante. Nkunku deve svegliarsi
milanClonate Pulisic! Il Milan non molla niente! Rabiot straripante. Nkunku deve svegliarsi
 interl'Inter vince ma i tifosi sono ancora scottati
interl'Inter vince ma i tifosi sono ancora scottati