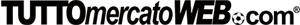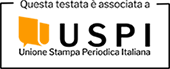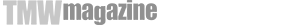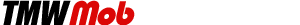TUTTO mercato WEB
TUTTO mercato WEBIl “difficile” concetto di giustizia quale valore etico e morale: nel calcio, nel mondo.
In un week end dedicato all’azzurro della Nazionale, prendiamoci una piccola pausa dai problemi strettamente legati al rettangolo erboso bianconero. Tudor o Spalletti? Brutto segno quando nell’ottobrata si parla di ballottaggio in panchina. Ne riparleremo fra qualche giorno. Intanto altri titoli bagnano d’inchiostro i quotidiani sportivi, quelli sui processi vecchi e recenti, sentenze, modalità di indagine e protagonisti di spicco che hanno “fatto” o giudicato. Articoli che nulla hanno a che fare – in apparenza – con schemi, panchine, pallonetti e gol, ma che fanno riflettere. Ci risiamo. Tra una partita ed un’altra, dentro una partita infinita fuori dal campo, ritorna sul tavolo da gioco la giustizia, orlata da scudetti di cartone, plusvalenze, chineate, querele, gravinate e figciate. Strano, perché la giustizia, quella vera, basterebbe a se stessa, senza questi orpelli.
La giustizia nel mondo omerico e arcaico non è concepita come un sistema di leggi scritte, ma come un ordine stabilito: Θέμις (Thémis) e Δίκη (Dike). Themis rappresenta la giustizia sacrale, divina e consuetudinaria. Indica ciò che è "posto" dagli dèi, le norme che regolano l'ordine cosmico, le istituzioni sociali fondamentali e le decisioni dei re, in quanto ispirate dagli dèi. È l'antenata di ogni legalità e ha un carattere autoritario. Dike rappresenta la giustizia come conformità a una direzione corretta. Inizialmente, nei poemi omerici, è il giudizio, la sentenza, la sanzione. In Esiodo la giustizia divina è invocata contro i "re divoratori di doni" (basileis dōrophágoi). Il poeta afferma che la Dike è un principio morale e di buon governo (Eunomia) che, se violato, porta alla rovina della comunità (Hybris). Il concetto qui inizia a secolarizzarsi, diventando la norma che dovrebbe regolare i rapporti umani, anche se ancora garantita dagli dèi.
Con l'emergere della polis e la crisi dell'aristocrazia, il concetto di giustizia si sposta dalla sfera divina a quella politico-giuridica. Con le riforme di Solone nel VI secolo a.C. ad Atene, la giustizia si identifica con l'Eunomia (buon governo) e l'Isonomia (uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge). La giustizia diventa l'equilibrio politico e sociale garantito da leggi scritte che limitano l'arbitrio e mediano i conflitti tra le classi. La Dikē diventa sempre più il principio della legalità cittadina. Per Socrate la giustizia è una virtù dell'anima. Essere giusti è un bene in sé, che rende felice chi lo pratica. L'ingiustizia danneggia l'anima di chi la commette ed è un male peggiore del subirla. La giustizia è strettamente legata alla conoscenza del bene e al rispetto delle leggi della polis (anche se ingiuste, come nel suo caso). Platone, il maestro di Aristotele, sviluppa il concetto a un livello metafisico e politico e vede la giustizia come armonia dell'anima e dello stato.
Nella sua celebre opera Etica Nicomachea, Aristotele eleva la giustizia al rango di virtù suprema. In una società che ambisce a essere giusta, questa virtù non solo regola i rapporti tra le persone, ma rappresenta un modello di perfezione morale: «La giustizia è la virtù più efficace, e né la stella della sera, né quella del mattino sono così meravigliose, e citando il proverbio diciamo: nella giustizia ogni virtù si raccoglie in una sola. Ed è una virtù perfetta al più alto grado perché chi la possiede è in grado di usare la virtù anche verso gli altri e non soltanto verso se stesso».
Aristotele, con il rigore che caratterizza il suo pensiero, ci invita a considerare la giustizia non solo come una qualità individuale, ma come un principio universale che trova la sua massima espressione nel rapporto con gli altri, tanto è che la definisce come la più efficace tra le virtù perché raccoglie in sé tutte le altre qualità morali. Non è sufficiente essere coraggiosi, temperati o saggi per essere giusti: la giustizia, infatti, implica che queste virtù siano utilizzate in modo equilibrato e sempre orientate al bene comune. Paragonandola a un fenomeno naturale sublime – le stelle del mattino e della sera – Aristotele sottolinea la bellezza e l’unicità della giustizia. È una bellezza che va oltre il semplice rispetto delle regole, poiché la giustizia non si limita a essere un codice etico, ma è intrinsecamente legata all’armonia dell’universo e alla felicità dell’individuo. Una parte fondamentale della riflessione aristotelica risiede nell’affermazione che “nella giustizia ogni virtù si raccoglie in una sola”. Questa affermazione implica che la giustizia non è una virtù separata, ma il culmine di un percorso morale che include tutte le altre virtù, quali la saggezza, la moderazione e il coraggio. Essere giusti, quindi, significa raggiungere una sintesi armoniosa delle virtù, alias i giudici dovrebbero esser virtuosi.
L’aspetto che rende la giustizia una virtù perfetta, secondo Aristotele, è la sua dimensione interpersonale, relazionale: riguarda il modo in cui un individuo interagisce con gli altri, assicurando che ognuno riceva ciò che gli è dovuto. In altre parole, la giustizia estende l’ambito della virtù individuale all’intero contesto sociale. Questo implica che il giusto non agisce solo per il proprio interesse, ma riconosce e rispetta i diritti e i bisogni altrui. La giustizia diventa lo strumento attraverso cui la virtù si concretizza nelle relazioni umane. Per Aristotele, il giusto si identifica spesso con l’equilibrio. Questa idea si collega al concetto del “giusto mezzo” che attraversa tutta la sua etica: la virtù consiste nell’evitare gli estremi e nel trovare una via di mezzo proporzionata e appropriata a ogni situazione. La giustizia non è un ideale astratto ma un impegno quotidiano. È una virtù che richiede consapevolezza, responsabilità e coraggio: la consapevolezza di ciò che è giusto, la responsabilità di agire in modo equo e il coraggio di difendere la giustizia anche in situazioni difficili. Con le sue parole immortali, Aristotele ci invita a riflettere su cosa significhi essere giusti, non solo come individui ma come membri di una comunità. È un invito a coltivare la virtù nella nostra vita quotidiana, trasformando la giustizia in una luce guida, meravigliosa come la stella del mattino.
È tanto difficile tutto questo, o per caso è soltanto molto ingombrante per alcuni sedicenti virtuosi? L’Italia, patria di grandi giuristi, e gli Italiani, sono stanchi di veder soffrire quella divinità raffigurata con la bilancia (simbolo della valutazione e dell'equilibrio delle prove) e la spada (simbolo del potere di punire il male), e talvolta con una benda sugli occhi, a indicare l'imparzialità.
E se cade il valore etico, figuriamoci lo strumento formale che è la legge, cioè quell’insieme di norme positive che regola la convivenza sociale. La legge è uguale per tutti. È una bella frase che rincuora il povero, quando la vede scritta sopra le teste dei giudici, sulla parete di fondo delle aule giudiziarie; ma quando si accorge che, per invocar la uguaglianza della legge a sua difesa, è indispensabile l'aiuto di quella ricchezza che egli non ha, allora quella frase gli sembra una beffa alla sua miseria. Chissà, forse Piero Calamandrei non si riferiva solo alla ricchezza materiale dell’imputato.
Che un giorno (altamente utopico) si possa parlare solo di calcio giocato, al massimo dialogare col barista se Tudor riuscirà a mangiare il panettone, o se a papparselo “giustamente” sarà mister Spalletti.
Roberto De Frede
 juventusLa meraviglia di Napoli-Juventus
juventusLa meraviglia di Napoli-Juventus
 fiorentinaDa De Gea a Kean, passando per Dodo. Fiorentina tradita dai suoi senatori
fiorentinaDa De Gea a Kean, passando per Dodo. Fiorentina tradita dai suoi senatori
 napoliIl doppio ex Giaccherini: "Conte si mise in gioco per me! Nel Napoli uno come me..."
napoliIl doppio ex Giaccherini: "Conte si mise in gioco per me! Nel Napoli uno come me..."
 romaCagliari-Roma - Le probabili formazioni. GRAFICA!
romaCagliari-Roma - Le probabili formazioni. GRAFICA!
 livornoL'uomo venuto dal Nord
livornoL'uomo venuto dal Nord
 fiorentinaFiorentina Primavera, la formazione ufficiale per la sfida contro il Napoli
fiorentinaFiorentina Primavera, la formazione ufficiale per la sfida contro il Napoli