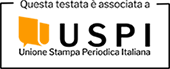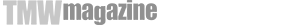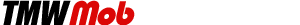Clemente di San Luca: "L’essenza del calcio e l’ipocrisia”
Guido Clemente di San Luca, Docente di Giuridicità delle regole del calcio presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Vanvitelli, si è espresso così ai nostri microfoni: "Nell’ultimo pezzo ho provato a fare chiarezza sulla preoccupante confusione che si fa tra morale e diritto e su quanto sia indispensabile tenerle concettualmente distinte. Gli accadimenti dell’ultima giornata di campionato hanno dimostrato quanta se ne faccia, rendendo indispensabile riflettere sulla ipocrisia. Che è stata messa definitivamente in mostra, in maniera tanto clamorosa quanto sconsolante, da parte di allenatori, calciatori, istituzioni & arbitri, e commentatori (giornalisti od opinionisti che siano). Dicesi ‘ipocrisia’ la «simulazione di virtù, e in genere di buoni sentimenti, di buone qualità, per guadagnarsi la simpatia o i favori di una o più persone, ingannandole». Ebbene, essa pervade il sistema calcio italiano in tutte le sue componenti. Sulla verità dei fatti nella loro evoluzione storica, rinvio ai documentati racconti ‘ricognitivi’ di Paolo Ziliani (non solo nei pezzi sul Fatto quotidiano, ma specialmente) nella pubblicazione, supportata dai lettori, «Palla avvelenata». Considerando corretta la sua narrazione dei fatti, cercherò di derivare da essa una riflessione sulla diffusa e generalizzata ipocrisia, a partire da un essenziale richiamo alla definizione del gioco del calcio, che lo rende uno sport assai poco assimilabile agli altri. Come si definisce lo sport? Allo scopo di riflettere su quale sia la sua essenza e sul se e come il calcio si distingua da tutti gli altri, bisogna intendersi prima sulla definizione di sport. Almeno convenzionalmente, esso dovrebbe consistere nell’attività fisica o mentale che implica competizione, regole precise e spesso un elemento di divertimento o svago, con l’obiettivo di vincere o di migliorare sé stessi. In questa definizione, gioca un ruolo chiave la ricerca della vittoria: è il motore che spinge gli atleti a competere con gli avversari e a superare i propri limiti. Senza tale ricerca, lo sport sarebbe solo mera attività fisica. Certo, in essa la componente fisica conta moltissimo: per ottimizzare la prestazione ed esprimere al meglio le abilità tecniche, sono fondamentali resistenza, forza, velocità, agilità. Caratteristiche necessarie in tutti gli sport. Ma in alcuni ce n’è una di più: l’astuzia. Nel gioco del calcio più che in ogni altro. Cosa distingue, caratterizza e rende unico il calcio rispetto agli altri sport? L’essenza del calcio è apparentemente semplice: segnare un gol in più dell’avversario. In realtà, è al tempo stesso assai complessa, giacché per fare quel gol in più occorrono, oltre alle richiamate caratteristiche, anche altri requisiti, che derivano dalla imprescindibilità del lavoro di squadra: le attitudini strategiche e tattiche. Nell’esplicitare le quali, tuttavia, è comunque indispensabile che ogni singolo giocatore contribuisca secondo le proprie qualità individuali. Fra queste spiccano il toccare la palla con classe ed eleganza, l’improvvisazione, la creatività e, appunto, l’astuzia. Nell’essenza del calcio, allora, hanno un ruolo imprescindibile e centrale l’arte della finta, la capacità di leggere il gioco per anticipare le mosse dell’avversario, e di ingannarlo con abilità e scaltrezza, creandosi opportunità per sconfiggerlo. Detto altrimenti, l’essenza del calcio è il dribbling. Che cos’è un dribbling? Secondo la Treccani, è la «manovra individuale dell’atleta che consiste in leggeri tocchi del piede, dati rapidamente al pallone, per portarlo da destra a sinistra o viceversa, così da ingannare l’avversario e scartarlo velocemente». A ben riflettere, quindi, nulla più del dribbling incarna l’essenza del gioco del calcio. È vero che l’espressione si usa «anche a proposito di altri sport a squadre (quali ad esempio la pallacanestro), ma è indubbiamente caratterizzante e tipica del calcio. Con le splendide parole di Jorge Valdano (Il sogno di Futbolandia, 2004), «lo specialista del dribbling è un giocatore di poker che bluffa con tutto il corpo e si gioca il pallone faccia a faccia con l’avversario: chi vince, se lo porta via. Fintare vuol dire ingannare con eleganza; si dà al marcatore un’informazione sbagliata e la riuscita del gesto dipende da come e quanto lui se la beve. Il resto consiste nel mettersi d’accordo col pallone per fuggire insieme. La vittima rimane indietro col dolore dello sconfitto e l’umiliazione dell’uomo sedotto e abbandonato.
Sarà per la prossima volta, bambolotto!». In queste righe preziose sta la migliore rappresentazione dell’essenza del calcio. Il dribbling è il suo cuore pulsante, il momento in cui il giocatore si esprime e crea qualcosa di unico. È il calcio allo stato puro. Ed il suo senso sta proprio nell’arte di ingannare l’avversario, di fintarlo, di farlo sbilanciare e di superarlo con astuzia. È un atto di creatività e di furbizia, un modo di vincere sull’avversario usando, non la forza, ma l’intelligenza e la tecnica. So bene che, in contrario avviso, si può sostenere che è solo uno degli aspetti e non l’essenza, perché il calcio è sport di squadra; strategia e tattica sono più importanti del singolo gesto tecnico; ciò che conta è conseguire il risultato. Sì, lo so, ci sono tanti modi per vincere (anche quelli illegali), e si può farlo senza saper dribblare. Il dribbling non è l’unica arma a disposizione. Nondimeno, appare innegabile che il tratto connotativo più definitorio di tutti resta il dribbling, con tutta la carica di ingannevolezza che porta in sé. Ora, non ci vuole molto a comprendere che appare fuori luogo, a proposito della simulazione, richiamare la deontologia dello sportivo in astratto. Mi pare, cioè, del tutto improprio evocare la bellissima immagine delle sciatrici giunte seconde, che s’inchinano davanti alla meravigliosa Brignone, per dare fondamento al disprezzo verso i calciatori ‘simulatori’. Si tratta di fenomeni non comparabili. Insomma, il fatto d’ingannare l’avversario è parte integrante e definitoria del gioco del calcio. Naturalmente, dentro il perimetro delle regole (giuridiche) stabilite per giocare. Il confine, dunque, tra legale e illegale, non sta nell’agire secondo un’etica che esclude l’inganno, giacché ciò finirebbe per azzerare il senso stesso del gioco. Il confine sta nell’accertamento di atti e comportamenti che violano le regole vigenti. Detto altrimenti, i giocatori hanno il diritto a tentare l’inganno. Ma, se viene provato che lo tentano, subiscono la sanzione. Senza dover meritare alcuna riprovazione morale. Ed è qui che sta l’ipocrisia. Le ipocrisie. È ipocrita, perciò, un allenatore, se, prima della partita, dichiara solennemente: «Quando vedrò un allenatore parlare con episodio a favore, verrò a parlare anch’io. Voglio vedere un allenatore venire in conferenza a dire “ho avuto un episodio a favore, chiedo scusa”». E dopo la partita, invece: «Per me è un tocco leggero, ma è un tocco. Bisogna dirlo, bisogna ammetterlo. Io quando ho subito errori così in Champions, ho sempre detto che non bisogna mettere l’arbitro in condizione di decidere»; «il mio giocatore sente la mano perché lo ha anticipato»; «un giocatore di esperienza come lui bisogna che le mani in certe circostanze le tenga a casa»; «un giocatore ammonito deve evitare di fare certi gesti che possono mettere in difficoltà l’arbitro»; «sapendo di essere ammonito poteva evitare di mettere la mano su un nostro giocatore». Dichiarazioni, le seconde, che sarebbero state irreprensibili se non avesse reso le precedenti. Ecco, questo corrisponde alla richiamata definizione di ipocrisia. Ma non c’è ipocrisia nell’affermare che «Il calcio è così da cento anni», che «Bisogna smettere di fare i moralisti», che «Ogni domenica c’è un caso del genere, dai tempi di Maradona che fa un gol di mano al Mondiale». Perché questo è vero, e non criticabile. E, anzi, è incoerente chiedere di «lasciar stare a casa Diego» senza spiegare le vere ragioni della sua immensità, se poi si riconosce che riuscì a «vincere quella partita» prima con «un colpo d’astuzia» e poi con «un altro di classe» (è falso, invece, che «Nessuno gli ha mai detto nulla», perché gliene hanno dette di tutti i colori; e che «anche noi a Napoli abbiamo subito un torto, e lo dico per la prima volta, ma non abbiamo reagito così», perché non hanno affatto subito un torto, sono solo a digiuno delle regole). Sono ipocriti quei calciatori che, dopo aver speso la loro carriera nel segno della vittoria ad ogni costo, puntando a condizionare prepotentemente arbitri e avversari, la simulazione impunita essendo il più lieve dei loro peccati, gracchiano moralismo dai pulpiti televisivi, giungendo persino ad assimilare l’intenzionale volo di Bastoni al fallo subito da Vergara (l’uno simula in violazione della norma, l’altro subisce uno sgambetto: un’operazione intellettualmente disonesta). Sono ipocriti quegli esponenti delle istituzioni – AIA e FIGC – che non hanno perso occasione per crocifiggere il signor La Penna, il quale, sì, ha commesso un indiscutibile errore (che ha scatenato l’inferno solo perché ai danni dell’intoccabile Juventus).
Ma uno di quelli rientranti nella categoria degli «errori scusabili». Addirittura, s’è sentito invocare il ‘buon senso’ come causa legittima di un uso improprio del VAR (a proposito del quale, invece, si sentenzia costantemente ripetendo che «in questo caso non può intervenire»). Nella fattispecie non si poteva correggere l’errore in autotutela (per una lacuna normativa cui l’IFAB pare stia rimediando). Mentre invece – è questo il vero vulnus – molto di frequente assistiamo attoniti ad episodi in cui, pur potendo/dovendo intervenire per rimediare all’errore scusabile, il VAR omette di farlo, trasformandolo in «errore intenzionale»: vedi, in Napoli-Roma, il mancato intervento per l’espulsione di N’Dicka (fallo da ultimo uomo) e quella di Wesley (fallo di reazione violenta). Uno scandalo solare a proposito del quale si esprimono con lingua biforcuta molti esponenti del giornalismo televisivo e della carta stampata, non solo allenatori e calciatori. Sono ipocriti pure quegli esponenti dell’UEFA, quando, nel riferire delle prossime ‘linee guida’ sul VAR, dichiarano che «Forse abbiamo dimenticato tutti perché è nato. Il VAR è nato per errori chiari e ovvi. Sulle decisioni fattuali, come il fuorigioco, lavora alla perfezione. Ma sulle interpretazioni il discorso è diverso. La UEFA preferisce intervenire meno al video e lasciare la decisione sul campo. Ci perderemo un rigore ogni tanto, però non si danno quelli francamente inesistenti. Ne riparleremo con i designatori federali. Dobbiamo ritrovare i principi originari». Aggiungendo che i ‘punti chiave dell’arbitraggio’ «sono la protezione dei giocatori, prima di tutto; la lotta all’esagerazione dei contatti lievi; l’interpretazione del ‘mani’; la lotta agli attacchi al portiere per impedirgli di giocare e, infine, l’importantissimo rapporto arbitro-capitano per spiegare le decisioni in campo». È palese l’intenzione di rinsaldare il potere arbitrario degli arbitri, svuotando di pregnanza il VAR, l’unico strumento in grado di assicurare la legalità. S’invoca a sproposito il ‘senso del gioco’ solo per conservare potere, non per garantire che questo si svolga correttamente. Come a voler dire: «basta con la riduzione degli spazi di valutazione, si deve tornare a ridare lo scettro al principe, all’arbitro». Sarebbe certificato così il definitivo ritorno alla cultura medievale".
 parmaUnder 14, gialloblù in casa contro il Sassuolo per consolidare il primo posto
parmaUnder 14, gialloblù in casa contro il Sassuolo per consolidare il primo posto
 interDall'Argentina, i tempi di recupero di Lautaro sarebbero più brevi: si stima...
interDall'Argentina, i tempi di recupero di Lautaro sarebbero più brevi: si stima...
 veneziaVenezia, Stroppa: "Attenzione al Pescara, è in salute. L'obiettivo è troppo importante per non avere le giuste motivazioni"
veneziaVenezia, Stroppa: "Attenzione al Pescara, è in salute. L'obiettivo è troppo importante per non avere le giuste motivazioni"
 interIl Direttore Lapo De Carlo a teatro con Nerazzurra Show. I dettagli...
interIl Direttore Lapo De Carlo a teatro con Nerazzurra Show. I dettagli...
 milanLeao, talento e gestione: il peso di una stagione a mezzo servizio
milanLeao, talento e gestione: il peso di una stagione a mezzo servizio
 salernitanaSalernitana, spunta un retroscena di mercato: i dettagli
salernitanaSalernitana, spunta un retroscena di mercato: i dettagli
 romaL’arbitro - Bilancio vincente con Di Bello: 6 successi consecutivi, ultima sconfitta nel 2021/22
romaL’arbitro - Bilancio vincente con Di Bello: 6 successi consecutivi, ultima sconfitta nel 2021/22