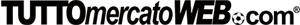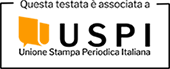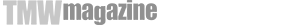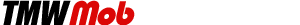TUTTO mercato WEB
TUTTO mercato WEBLegge Bove, Abodi: "Grazie a Edoardo e a chi non c'è più. Vediamo se ce la faremo"
In occasione della conferenza stampa per la presentazione della Legge Bove sul primo soccorso - tenutasi oggi presso l'aula convegni del Palazzo Carpegna in Senato - è intervenuto il Ministro allo Sport Andrea Abodi: "Grazie, buonasera. Come dire, ci sono cose che dovrebbero unirci, ma che non sempre vanno come dovrebbero, perché quella che avete raccontato è una storia di tentativi. Quindi il ringraziamento va a Marco per questa opportunità, ma prima di tutto a Diego Tavano e a Edoardo Bove, perché sono loro che mi hanno “precettato”. Sapevo poco, ho letto la documentazione che mi è stata predisposta e, a un certo punto, qualcuno mi ha detto che sarei stato l’unico ministro a intervenire, ma l’unico non citato. Non perché volessi esserlo, ma la verità è che per essere coinvolti in una situazione come questa non serve un motivo personale: ci vuole una sensibilità che va ben oltre, anzi che la precede.
C’è forse una ragione che non conoscete, che riguarda anche la mia vita. Io mi sono confrontato con questa problematica che colpisce 65.000 persone l’anno, un numero pazzesco. Se non ce ne rendiamo conto, diventa routine: ci abituiamo troppo facilmente a tutto. Le Torri Gemelle hanno devastato la vita di 3.000 persone, una volta. E qui ogni anno c’è una guerra silenziosa, come altre guerre silenziose: penso agli incidenti stradali e a ciò che comportano, a ciò che lasciano.
A me è successo 40 anni fa. All’improvviso, un mio cugino di 13 anni, giocando a pallone d’estate con i suoi amici, è andato giù ed è rimasto per terra. Era un tempo diverso: meno conoscenza, meno informazione, meno consapevolezza. Ma oggi non siamo più nella condizione di poter lasciare che le cose succedano, e accorgercene come opinione pubblica solo quando colpiscono una figura conosciuta. Quei 65.000, quella persona ogni sette minuti, sono la somma di dolori che non possiamo non ascoltare, non vedere.
Allora la domanda è: come mai in dieci anni non siamo riusciti ad andare avanti? Potremmo mai dire che è un problema di costi? La prima considerazione è: qual è il valore di una vita? Possiamo dire che esiste una percezione della vita che comprendiamo davvero solo quando ci tocca da vicino? Probabilmente sì. Manca forse una cultura della vita, che si manifesta in tanti aspetti: nella vita negata e nella vita che non nasce. Tematiche che tutte insieme dovrebbero impegnarci molto di più.
Non so cosa pensino i miei colleghi di governo di questo percorso, ma sono convinto che li troveremo tutti attorno a un tavolo. Perché sì, è sempre presente il Ministero dell’Economia, ma di fronte a un tema proposto così, al di là delle valutazioni di ciascuno, non possiamo che stare dalla stessa parte. Lo dobbiamo alle persone che conosciamo e a quelle che non conosciamo, ma che riconosciamo nello stesso dolore.
Penso a Matteo, e a tutte le realtà che hanno cercato di dare un senso alla vita negata attraverso un impegno rinnovato e solidale, in cui ci si ritrova come ci si conoscesse da sempre, anche se non è così. Siamo tutti sulla stessa barca, viviamo tutti la stessa avventura della vita. E diventa incomprensibile che non si riesca ad associare la formazione e l’educazione su questi temi al tema prioritario, che è la vita. Nelle agende educative questo tema non entra quasi mai. Se ne parla incidentalmente.
Parliamo spesso di rispetto, una parola chiave: se si ha sensibilità per il rispetto in tutte le sue forme, il rispetto della vita diventa naturale, prioritario. Voglio vedere cosa resterà, al 31 dicembre, di questo “anno del rispetto” che Treccani ha scelto: perché la sensibilità non è mai abbastanza. La cronaca ci dimostra quanto ce ne sia bisogno ogni giorno, nel nostro modo di pensare, agire e relazionarci. Vale per le questioni planetarie, ma penso che se il mondo decide tante cose, quelle poche che restano nelle nostre mani dobbiamo gestirle bene, presto e insieme.
Quindi, in conclusione — che non è una conclusione, ma una chiusura che presuppone un nuovo inizio — questo impegno deve appartenere a tutti noi. È gratificante, per chi ha responsabilità istituzionali, capire che siamo capaci di non dividerci su ciò su cui siamo tutti d’accordo. La vita non può che essere al centro delle nostre scelte. Non solo per noi qui oggi, ma per i più fragili, i più deboli, i più piccoli, ai quali dobbiamo un impegno maggiore. Non possiamo dire loro “non ci siamo riusciti”, “non si può fare”, “non l’abbiamo mai fatto”.
Questi dieci anni valgono un impegno rinnovato, che riguardi tutti. Perché nella scuola è possibile e necessario insegnare il rispetto della vita, la cultura della vita, attraverso tutte le forme che permettono alla vita di preservarsi. Vale per l’università, per chi forma, per la salute, perché è un tema primario. A volte c’è la sensazione che nel mondo della salute ci sia bisogno di malati, mentre noi abbiamo bisogno di salute. Vogliamo arrivare prima, perché arrivare dopo — dire parole di circostanza e non sempre poter gioire per lo scampato pericolo — non ci basta più.
Quello che è successo a te è successo, in forme diverse, anche ad altri uomini dello sport. Morosini l’ho vissuto in prima persona, da presidente della Lega B, era un ragazzo di una nostra squadra. Vale per Bovolenta, vale per Astori. Tutti cercano di mantenere viva la sensibilità e l’attenzione, per dare un senso a chi resta e al sacrificio di chi se n’è andato. Eppure non è mai sufficiente. Anche in questi giorni leggiamo di due runner morti improvvisamente, della stessa società, di notte. Sembra una categoria colpita da una patologia inspiegabile, imprevedibile. Non è così. Certo, se arriviamo a farci un certificato falso pur di correre, è chiaro che diventa più facile correre dei rischi. Il rischio non si azzera: si contiene, si limita, si previene in qualche modo. Ma questo presuppone la conoscenza dei rischi. Al di là del fatto che penso che ognuno sia artefice del proprio destino, lo Stato e le istituzioni hanno il dovere di mettere ogni cittadino nelle condizioni di preservare sé stesso, i propri cari e anche gli altri.
E lo sport ha una responsabilità che deve saper amministrare, per ciò che rappresenta come fattore di socialità e come strumento, canale di comunicazione e di informazione. Questo diventa ancora più vero non solo quando in ogni impianto c’è un defibrillatore — che non vorrei fosse soltanto un modo per dire “abbiamo rispettato la regola” — ma quando quel defibrillatore funziona e quando ci sono persone in grado di usarlo nel momento del bisogno. Non è un adempimento burocratico: è un salvavita a tutti gli effetti.
E allora mi domando perché i protocolli formativi di allenatori, istruttori e maestri di ogni disciplina non prevedano, oltre alla buona educazione — che credo vada insegnata per poter essere a propria volta insegnata, e chi non è in grado di rappresentarla non può insegnare — anche la capacità di apprendere e insegnare il primo soccorso. Perché l’insegnamento, a qualsiasi livello, è una missione: o se ne è consapevoli, sapendo che va ben oltre la materia specifica o la disciplina sportiva, oppure non si può svolgere questo ruolo. È questo il senso della Costituzione: il valore educativo e sociale che riconosciamo allo sport, e il benessere psicofisico che vogliamo preservare in tutte le sue forme.
Alla base c’è il fatto che chi insegna deve aver acquisito competenze e conoscenze e deve poterle trasferire. Perché nei protocolli del settore tecnico di tutte le federazioni non è prevista anche la formazione sul primo soccorso?
Abbiamo un sacco di cose da fare. Non è una conclusione: qui non c’è un punto, c’è una virgola. Adesso sta a noi. Abbiamo riempito un po’ di pagine di cose da dire e da fare, ma ne restano molte bianche: compiliamole insieme.
Al di là degli aspetti finanziari, che vanno valutati con attenzione per evitare azioni improprie, dobbiamo saper attribuire un senso a ogni euro necessario per implementare questa misura. Credo che il consenso che possiamo raccogliere tutti insieme — governo, Parlamento e società civile — possa consentirci un iter rapido, senza superficialità. Le procedure parlamentari permettono di procedere velocemente, ma con rigore, nelle due Commissioni e quindi arrivare presto in Aula.
Vediamo se riusciamo a farlo: grazie a Edoardo, ma soprattutto grazie a chi non c’è più, alla loro memoria e al rispetto che dobbiamo a chi li ha amati e continua a vivere nel dolore. Vediamo se ce la faremo. Io sono fiducioso”
Altre notizie
Ultime dai canali
 napoliLucca, l'ex agente: "Ha sempre mal digerito il poco minutaggio, ma ci si aspettava di più"
napoliLucca, l'ex agente: "Ha sempre mal digerito il poco minutaggio, ma ci si aspettava di più"
 romaL'attacco della Roma torna a popolarsi: recuperati Ferguson e Bailey. Calciomercato Roma - Per l'attacco si valutano anche Scamacca e Krstovic
romaL'attacco della Roma torna a popolarsi: recuperati Ferguson e Bailey. Calciomercato Roma - Per l'attacco si valutano anche Scamacca e Krstovic
 cagliariCosenza, la gioia social dell'ex Cagliari Achour: "Tre punti fuori casa, proseguiamo verso il nostro obiettivo"
cagliariCosenza, la gioia social dell'ex Cagliari Achour: "Tre punti fuori casa, proseguiamo verso il nostro obiettivo"
 napoliDa Bergamo: "Palladino è orientato a scegliere questo modulo contro il Napoli..."
napoliDa Bergamo: "Palladino è orientato a scegliere questo modulo contro il Napoli..."
 atalantaPalladino punta su De Ketelaere: a Zingonia riparte la Dea che vuole ritrovare gol e identità
atalantaPalladino punta su De Ketelaere: a Zingonia riparte la Dea che vuole ritrovare gol e identità
 atalantaL'ex Ruggeri si racconta: "All’Atlético mi sento a casa. Gasperini mi ha costruito, in Simeone rivedo la stessa intensità"
atalantaL'ex Ruggeri si racconta: "All’Atlético mi sento a casa. Gasperini mi ha costruito, in Simeone rivedo la stessa intensità"
 napoliChiariello: "Il Napoli è un intruso nella geografia del potere. Rivincere lo Scudetto va oltre lo sport"
napoliChiariello: "Il Napoli è un intruso nella geografia del potere. Rivincere lo Scudetto va oltre lo sport"
 romaCremonese, Midtjylland e Napoli in 7 giorni: è già il momento di puntare forte allo scudetto?
romaCremonese, Midtjylland e Napoli in 7 giorni: è già il momento di puntare forte allo scudetto?
Primo piano