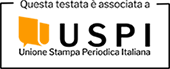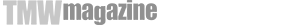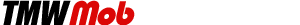TUTTO mercato WEB
TUTTO mercato WEBQuando il David Granata fermò il Golia Partenopeo
Quando il presente pesa come un macigno e la Serie C sembra un labirinto senza uscita per la Salernitana, la mente corre inevitabilmente verso quei momenti di gloria che hanno reso radioso l'essere tifosi granata. Sono i ricordi delle imprese impossibili, delle vittorie strappate con i denti che diventano balsamo per lenire le ferite del presente. Ed è proprio a queste epopee recenti che torno, come un pellegrino che cerca conforto nei santuari della memoria, per ritrovare la forza di credere ancora.
I derby campani della Salernitana non sono mai stati semplici incontri sportivi. Sono cerimonie laiche in cui si celebra e si combatte per qualcosa di più antico del pallone: il diritto di esistere, di gridare la propria differenza e di rivendicare quell'identità che la geografia e la storia le hanno regalato. Come negli antichi poemi omerici, dove ogni eroe portava sullo scudo lo stemma della propria città, così ogni tifoso granata che attraversa il confine per un derby porta con sé il peso e l'onore di rappresentare Salerno, città di frontiera, da sempre sospesa tra mare e montagna, tra bisogno di appartenenza e desiderio di distinzione.
Il derby con il Napoli è il più letterario di tutti, quello che più si avvicina al confronto tra Davide e Golia. C'è il gigante, la metropoli che tutto divora con la sua fame di primato, e c'è il piccolo guerriero ma non meno fiero, che sa di partire sfavorito eppure scende in campo con quella dignità che solo chi ha poco da perdere può permettersi. Partiamo dall'epico 2-1 dell'aprile 1948 all'Arechi, quando la Salernitana di Edmondo Fabbri - sì, quel Fabbri che poi avrebbe guidato la Nazionale - fermò il Napoli di Amadei davanti a ottomila anime in delirio. Non era solo calcio, quella domenica. Era l'affermazione che esistevamo, che la nostra voce contava, che non eravamo solo "quelli vicino a Napoli" ma qualcosa di distinto e vitale.
La rivalità con Napoli ha sempre avuto un sapore particolare, amaro e dolce insieme come il limoncello che si beve guardando il Golfo.
C'è stato un altro momento in cui l'impossibile diventa tangibile, quando il calcio smette di essere geometria e tattica per trasformarsi in pura poesia. Accade nell'attimo in cui Boulaye Dia, quel ragazzone senegalese con la maglia granata addosso, stoppa il pallone al limite dell'area, fa un euro-tunnel a Osimhen e lascia partire un sinistro che va a morire nell'angolino gelando un Maradona attonito. È il 29 gennaio 2023, Napoli-Salernitana 1-1, e in quella frazione di secondo si compie un'impresa che ha il sapore dell'epica antica: fermare la capolista inarrestabile, rovinare la festa del padrone, dimostrare che il calcio, qualche volta, sa ancora essere sorprendente.
Aurelio De Laurentiis aveva già fatto preparare il festone. I fuochi d'artificio erano pronti, le bottiglie di champagne in ghiaccio, la scenografia perfetta per celebrare l'ennesima tappa trionfale verso lo scudetto che poi sarebbe effettivamente arrivato. Ma aveva fatto i conti senza l'oste e così il buffet che aveva già preparato gli rimase sullo stomaco (catering per 350 persone). “Ce lo stiamo trezziando chianu chianu…”, cercò di sdrammatizzare Spalletti. De Laurentiis invece se la prese così a male che decise di non seguire la squadra nella successiva trasferta di Udine. Aveva dimenticato, il presidente partenopeo, che esistiamo. Che cinquanta chilometri non sono abbastanza per cancellarci.
Quel pareggio ha avuto il sapore delle grandi imprese storiche. Il Napoli di Spalletti dominava il campionato con una superiorità quasi imbarazzante: ventuno vittorie in ventidue partite, un vantaggio di quindici punti sulla seconda. E noi, impantanati al 14° posto in classifica, con addosso quella sensazione di chi sa che ogni punto può significare salvezza o Serie B.
Tecnicamente, Paolo Sousa aveva preparato la partita con l'umiltà del guerriero che conosce il proprio posto nel mondo. Difesa a cinque, centrocampo folto, Dia unica punta con licenza di vagare alla ricerca dello spazio giusto. Era il calcio della necessità, quello che non cerca la bellezza ma l'efficacia, quello che sa di dover resistere per ottantanove minuti per poi mordere nell'unico attimo di distrazione dell'avversario. E così è stato. Kvara aveva illuso De Laurentiis al 62', ma Dia ha ristabilito quella giustizia poetica che solo lo sport sa dispensare quando decide di essere magnanimo.
Ma se il derby con Napoli è la sfida contro il padre ingombrante, quello con l'Avellino è il regolamento di conti tra fratelli. E i fratelli, si sa, sono quelli che conoscono i tuoi punti deboli, quelli con cui hai condiviso l'infanzia difficile della provincia campana, quelli che ti assomigliano troppo per poterli amare senza odiarli un po'.
Il 15 ottobre 2017, stadio Partenio-Lombardi. Serie B, trentatreesima giornata. Chi c'era quella sera non la dimenticherà mai, perché certe partite trascendono il risultato per diventare racconto, leggenda, mito da bar Sport. Avellino-Salernitana, l'eterno confronto tra chi abita le valli e chi guarda il mare. Novantacinque minuti di battaglia medievale, duelli feroci, cartellini gialli che piovevano come foglie d'autunno. Avellino avanti 2-1, poi arriva il pareggio con Mattia Sprocati al 85° e poi arriva il minuto novantasei, quel tempo sospeso dove tutto può ancora accadere. Joseph Minala, camerunese prestato dalla Lazio, riceve palla al limite dell'area. Un attimo di esitazione, poi il destro che si infila dove Frattali non può arrivare. 2-3. L'esplosione. Non è solo un gol della vittoria, è la rivendicazione di esistere fino all'ultimo secondo, di non arrendersi mai, di combattere anche quando la logica suggerirebbe di mollare.
Quella sera il pullman che riportava i tifosi granata da Avellino a Salerno sembrava una nave di reduci vittoriosi. Nei bar del centro, fino a notte fonda, si è bevuto e cantato come se avessimo vinto lo scudetto. Perché vincere ad Avellino, per noi, vale più di qualsiasi altro successo. È una questione viscerale, tribale, che affonda le radici in una rivalità fatta di geografia, economia, identità. Avellino è l'interno, noi siamo la costa. Loro sono le montagne, noi il mare. Loro la provincia chiusa, noi la città aperta al Mediterraneo. Sono differenze che sulla carta del Touring Club sembrano minime, ma che nella vita vera pesano come macigni.
Tatticamente, quella vittoria fu un capolavoro di cinismo e opportunismo. La Salernitana di Gregucci aveva saputo soffrire, ripiegare, aspettare. Come facevano i pirati salernitani del Medioevo quando si nascondevano nelle insenature della costiera per poi piombare sui galeoni carichi d'oro. Pazienza, resistenza, colpo finale. Non è il calcio che piace ai puristi, ma è quello che serve quando sei in guerra.
C'è una frase di Alfonso Gatto, il nostro poeta di Salerno, che mi torna sempre in mente quando penso ai derby: "La patria è dove si nasce, la nazione è dove si sceglie di morire". Ecco, i derby campani sono esattamente questo: la rivendicazione della patria piccola, del luogo dove si nasce e a cui si appartiene con ferocia. Non è nazionalismo calcistico, è molto più intimo e viscerale: è il bisogno di dire "io vengo da qui" in un mondo che tende a uniformare, a cancellare le differenze, a rendere tutto intercambiabile.
 potenzaPicerno-Potenza, ecco dove vedere la partita in tv
potenzaPicerno-Potenza, ecco dove vedere la partita in tv
 potenzaPicerno-Potenza: previsioni meteo al "Donato Curcio"
potenzaPicerno-Potenza: previsioni meteo al "Donato Curcio"
 juventusPisa, esonerato Gilardino
juventusPisa, esonerato Gilardino
 juventusJuve, preso il vice-Yildiz. Romano: "Accordo per Boga in prestito con diritto di riscatto. Oggi sarà a Torino per visite e firma"
juventusJuve, preso il vice-Yildiz. Romano: "Accordo per Boga in prestito con diritto di riscatto. Oggi sarà a Torino per visite e firma"
 juventusAtletico Madrid, colpo a sorpresa: Marcos Leonardo vicino all’arrivo dall’Al Hilal
juventusAtletico Madrid, colpo a sorpresa: Marcos Leonardo vicino all’arrivo dall’Al Hilal
 romaIl paragone con Aldair per uno dei migliori difensori degli anni 2000: tanti auguri Juan. GRAFICA!
romaIl paragone con Aldair per uno dei migliori difensori degli anni 2000: tanti auguri Juan. GRAFICA!
 juventusBenzema-Al Ittihad, è rottura totale: crisi senza precedenti in Arabia Saudita, la Juve osserva
juventusBenzema-Al Ittihad, è rottura totale: crisi senza precedenti in Arabia Saudita, la Juve osserva
 napoliGutierrez a Dazn: "Nuovo ruolo? Sempre pronto per giocare. La vittoria è per Di Lorenzo"
napoliGutierrez a Dazn: "Nuovo ruolo? Sempre pronto per giocare. La vittoria è per Di Lorenzo"